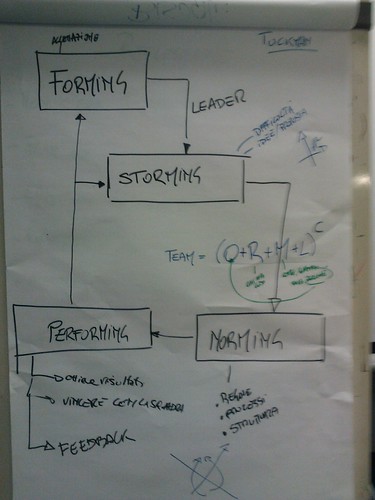Problem Solving
Prendi due o tre modelli di Problem Solving, aggregali, ed ecco quello che potrebbe emergere.
1. Definisci il problema
Wikipedia definisce il problema come “ un ostacolo che rende difficile raggiungere un determinato obiettivo o soddisfare una certa esigenza, frapponendosi tra la volontà dell'individuo e la realtà oggettiva”. Per definire bene il problema potrebbe tornare utile porsi le seguenti domande:
- Qual’è il problema ?
- E’ un mio problema ?
- Posso risolverlo ? Vale la pena risolverlo ?
- E’ questo il vero problema o semplicemente il sintomo di uno più grande ?
- Se questo è un vecchio problema, cosa c’è di sbagliato nella soluzione precedente ?
- C’è bisogno di una soluzione immediata o può aspettare ?
- C’è la possibilità che si risolva da solo?
- Posso ignorare il rischio ?
- Il problema ha dimensioni etiche ?
- Quali condizioni devono essere soddisfatte con la soluzione ?
- La soluzione può modificare qualche cosa che deve rimanere invariata ?
2. Raccogli le Informazioni
- Cerca tutte le informazioni che riguardano il problema siano esse fatti o dati numerici. Intervista esperti o fonti attendibili. Cerca eventi osservati, passati o presenti, sia personalmente o segnalati da altri.
- Identifica gli individui, i gruppi, le organizzazioni affette dal problema. Identifica i decisori e le persone importanti ed influenti.
- Identifica in modo chiaro e dettagliato il contesto (confini, vincoli, risorse, tempistiche, ….)
- Le opinioni dei decisori saranno importanti per il successo della vostra decisione. Nelle opinioni è importante riconoscere le verità dai pregiudizi. Le ipotesi possono farci risparmiare del tempo e del lavoro, perché spesso è difficile ottenere tutti i dati.
3. Sviluppa alternative
E’ il momento della Creatività. La tecnica del BrainStorming è sicuramente una delle migliori da applicare in questa fase.
4. Pesa le alternative
Dopo aver elencato le possibili alternative è importante pesarle e dare loro una “votazione”. In questa fase possono essere d’aiuto tecniche come la matrice di Thomas Saaty o la matrice SFF.
5. Seleziona le migliori alternative
Una volta pesate seleziona le migliori alternative, senza dimenticarsi però ….
- Non considerare alcuna alternativa come la “soluzione perfetta”;
- Ascolta le tue intuizioni o i tuoi stati d’animo;
- Vai da un estraneo di fiducia e chiedi il suo (esterno) Punto di Vista, potrebbe vedere cose che voi non vedete più;
- Considerate anche il compromesso, soprattutto quando si ha una piena comprensione del problema, e le vostre alternative possono dare origine ad una soluzione ibrida.
6. Implementa le soluzioni
E’ il momento di progettare l’implementazione delle soluzioni decise. Create un Piano d’Azione (Chi fa Che Cosa, Quando, Dove , Come e Perchè). Ricordatevi di informare chiunque sia interessato o toccato dal Piano d’Azione.
7. Monitora i progressi
L’implementazione avrà successo solo se verrà monitorato lo svolgimento, gli effetti sulle risorse e le parti interessate, la timeline ed i vostri progressi. Attenzione: se i risultati non sono quelli che ci si aspettava essere in grado di bloccare il Piano d’Azione. Studiando i risultati ottenuti dovrò decidere se implementare altre soluzioni elencate nel punto 5 o ritornare al punto 3 e sviluppare nuove soluzioni.
8. Check + Act
Come il ciclo di Deming ci insegna, qualsiasi sia il risultato ottenuto, sarà fondamentale per la nostra crescita fare un Check del processo elencando errori e successi e procedere con le azioni correttive o di standardizzazione (Act) necessarie.
Mappe Mentali alle Elementari
Finalmente le Mappe Mentali vengono insegnate già dalle scuole elementari ….. I miei complimenti alla maestra di Emma.

Distorsioni cognitive
Ripartendo dal Post precedente …… a volte leggiamo in modo errato gli stimoli che la Situazione ci porge. Beck ci propone una serie di “distorsioni cognitive”, degli errori di logica in cui cade il ns. emisfero sinistro e che influenzano poi in modo limitante l’interpretazione della Situazione che stiamo vivendo.
Ecco alcune delle principali distorsioni proposte da Beck:
- Pensiero dicotomico. Il soggetto accetta solo posizioni estreme: o tutto o niente. Questo tipo di ragionamento è molto pericoloso perché non permette l’esplorazione di alternative o strategie di apprendimento del tipo prova/errori.
- Interferenza arbitraria. Trarre conclusioni senza prove.
- Astrazione selettiva. Il soggetto si focalizza su un dettaglio e non percepisce il significato globale di tutta la situazione.
- Generalizzazioni. Estendere a tutte le possibili situazioni un’esperienza sfortunata e isolata.
- Doverizzazioni: eccessivo uso di espressioni tipo “dovrei", "devo", "bisogna", si deve" segnala un atteggiamento rigido e in diretta connessione con la presenza di regole personali.
- Etichettamento: etichettare una persona con una etichetta globale piuttosto che fare riferimento a specifici eventi o azioni.
- Ragionamenti Emotivi: considerare le proprie emozioni come valore della situazione reale (ad esempio si prova situazione di sfiducia e si conclude che la situazione è senza speranza).
- Riferimento al destino. L’individuo agisce come se il destino comandasse qualsiasi situazione. Tipica di persone con Locus of Control esterno.
Comportamentale
- altro: “di cosa di occupi ?”
- io: “formazione, faccio il formatore”
- altro: “ ah, davvero, e cosa insegni ?”
- io: “ beh, insegnare è una parola un po’ grande …. comunque mi occupo di comportamentale”
- altro (espressione perplessa): “comportame …. che ? non ho capito ….”
- permettere che le persone acquisiscano consapevolezza sui propri ed altrui Comportamenti;
- analizzare e valutare assieme ai partecipanti quali sono i Comportamenti più efficaci ed efficienti per determinate Situazioni;
- proporre “Modelli Comportamentali” ad hoc per determinate Situazioni (che poi la persona dovrà saper adattare/migliorare/personalizzare).
Barzellette
Ricordo un periodo della mia infanzia in cui andavano di moda le barzellette che iniziavano con “Ci sono un Italiano, un Tedesco ed un Inglese …..” Senza farla lunga andava sempre a finire che l’Italiano sapeva risolvere i problemi in modo creativo.
Questa ricerca di Linkedin (via Mauro Lupi’s blog) sulle parole più utilizzate nei profili rispetto alla nazione di appartenenza, mi ha fatto venire in mente le barzellette di infanzia.

Per gli Italiani la parola più usata è Problem Solving. Per i paesi di stampo anglosassone (USA, Inghilterra, Germania): Creatività.
Mi sorgono alcuni dubbi: nei paesi anglosassoni evidenziano la competenze “creatività” perché è un punto di forza rispetto alla loro tradizionale cultura organizzativa? In Italia la nostra tradizionale cultura a creare problemi ci ha veramente sviluppato anche la capacità di risolverli ?
Comunque il ricordo che ho delle barzellette è che l’Italiano risolveva sempre il problema, ma sempre con un artifizio e senza mai scoprire ed eliminarne la causa.
Cultura Organizzativa
T.E. Deal e A.A. Kennedy definiscono la Cultura Organizzativa un riflesso della “particolare miscela di valori e norme condivisi da persone e gruppi entro un’organizzazione, che fissano le modalità con cui interagiscono tra loro e con gli stakeholder al di fuori dell’azienda”1. Charlene Li aggiunge che “i Leader affermano questi valori non a parole, ma premiando azioni e punendo comportamenti:”2
1T.E. Deal e A.A. Kennedy, Corporate Cultures: The Rites and The Rituals of Corporate Life, Penguin, Harmondsworth, 1982 (trad. it. Cultura d’impresa, Itaca, Milano, 1994)
2Charlene Li, Open Leadership, Rizzoli Etas, 2011.
Open Leadership
Sto finendo la lettura di “Open Leadership, dirigere con successo nell’era dei Social Network”. L’autrice, Charlene Li, spiega come “l’essere aperti” sia al giorno d’oggi un approccio ragionato e rigoroso alla strategia e alla leadership. Sono molto d’accordo con l’autrice quando dichiara che i nuovi Leader oggi devono “lasciare andare” il controllo, a favore delle persone e dei collaboratori.
All’interno del testo Charlene identifica due caratteristiche fondamentali degli “Open Leader”: curiosità ed umiltà:
- curiosità: i Leader sono curiosi di conoscere il mondo intorno a loro perché cercano in modo insaziabile nuove opportunità per migliorare se stessi e ciò che li circonda.
- l’umiltà svolge un ruolo peculiare: permette ai leader di accettare nuovi punti di vista e di mettere in dubbio le proprie opinioni su certi temi, messi in discussione dall’analisi dettate dalla curiosità.
Curiosità ed umiltà portano poi i Leader a possedere due mentalità fondamentali: ottimismo e collaborazione. L’umiltà genera la fiducia, e a sua volta la fiducia genera un ottimismo nei confronti degli altri. I leader aperti condividono pensieri, sentimenti ed azioni. La seconda mentalità fondamentale è l’inclinazione alla collaborazione con i colleghi di un team, ma anche con persone di altri reparti aziendali e perché no, anche con i clienti esterni.
Incrociando queste due mentalità si ottengono 4 archetipi di Open Leader:
- il Realista Ottimista che riconosce vantaggi e limiti dell’apertura. Sa collaborare e dare fiducia agli altri, comprende il contesto, accoglie con entusiasmo il cambiamento e lo vede come un’opportunità. Possiede pazienza e segue il processo anche a livello operativo. Stringe relazioni profonde a tutti i livelli dell’organizzazione.
- l’Evangelista Trasparente è Ottimista ma fa fatica a collaborare, e per questo si ritrova ad essere un individualista. Gli manca la fiducia negli altri e fa fatica a mettere in dubbio il proprio punto di vista.
- lo Scettico Preoccupato è l’esatto opposto del Realista Ottimista: pessimista ed individualista. Pensa che il successo arrivi dalle forze e dalle competenze dei singoli; ritiene che il segreto del successo sia l’individualità. Non ama il cambiamento, non crede nella tecnologia, non si confronta con gli altri, perché non considera interessanti i loro punti di vista.
- Sperimentatore Cauto:è pessimista, ma comprende che senza collaborazione non si può procedere. E’ disposto ad ascoltare gli altri, ma il suo entusiasmo è temperato dal pessimismo.
Sicuramente le nuove modalità relazionali permesse dalla tecnologia (Social Network, blog, …) richiedono di sviluppare nuove competenze e comportamenti per i Leader. Il libro offre numerosi spunti e stimoli di riflessione, poi come al solito, la differenza i leader la faranno sul campo.
Comunicazione Emotiva
Emittente
E’ il soggetto (o l’oggetto) che emette il messaggio, solitamente una persona che ha un obiettivo, una ragione per entrare in comunicazione.
Ricevente
E’ il soggetto (o l’oggetto) che riceve il messaggio. Anche nella situazione in cui un soggetto parla e l’altro ascolta (esempio professore-alunno), il ricevente non è mai solamente passivo: nella realtà genera numerosi e continui messaggi di Feedback (verbali e gestuali) che vengono registrati dall’emittente e che influenzano il modo in cui il suo discorso si sviluppa. All’interno del processo comunicativo il ruolo che gioca il ricevente è di fondamentale importanza, o meglio della “comprensione” da parte del ricevente. Partendo dalla considerazione che il significato di ogni messaggio viene interpretato da parte del ricevente sulla base del proprio sistema cognitivo, l’elemento centrale della comunicazione è proprio il modo in cui il ricevente comprende il messaggio, comprensione che è sempre in una certa misura imprevedibile e incontrollabile.
Codice
Il codice è il sistema di segni dai significati condivisi che ci permette di comunicare. I significati, ovvero le cose che vogliamo comunicare, sono inizialmente solo all’interno della nostra mente. Per poter uscire all’esterno, debbono essere codificati, ovvero tradotti in suoni, gesti, segni che possiedano un significato condiviso. Se non fossimo in grado di associare a una serie di segni discreti dei significati (ed è la società che ci porta a conoscere questi codici insegnandoceli fin dai primi giorni di vita) non potremmo comunicare nulla, o quasi nulla. L’uomo dispone di una complessa serie di codici di cui può fare un uso creativo: ad esempio il linguaggio, o i gesti, ecc.
Codifica e Decodifica
Gli studiosi descrivono con l’espressione “codificare” l’attività che l’emittente compie per emettere un messaggio che sia effettivamente significativo per l’ascoltatore. La codifica si riferisce al processo attraverso il quale l’emittente trasforma le sue idee e le sue intenzioni in parole, o simboli di altro genere, nel tentativo di renderle comprensibili agli altri. Dunque, le idee vengono codificate in messaggi, i quali vengono inviati al ricevente, il quale compie il corrispondente processo di decodifica. La decodifica è la trasformazione delle parole e degli altri simboli ricevuti in un significato, che può essere simile, esattamente uguale o anche completamente differente rispetto al significato iniziale, quello che l’emittente aveva in mente quando ha codificato la sua idea. L’attività di codifica è resa non banale dal fatto che il codice non è sempre condiviso, e dunque la decodifica non è sempre corretta. Quando un medico descrive una patologia al paziente utilizzando il suo gergo tecnico, non si rende conto che il messaggio non è correttamente decodificabile da parte del ricevente, poiché solo l’emittente conosce il codice utilizzato.
Emozioni
L’uso del Codice è direttamente proporzionale allo stato emozionale. Possiamo semplicemente dire che il Codice è “COSA” l’emittente comunica…. le emozioni definiscono “COME” la comunica. Un’emozione di irritazione determinerà una comunicazione “irritata”, un’emozione di felicità causerà una comunicazione “allegra”.
Non Verbale
Nel caso di una comunicazione “viso a viso”, oltre alla voce entra in gioco tutta la comunicazione non verbale. Il mondo del non verbale è molto vasto, mi limiterò ad una tabella riassuntiva:
| Forme: | Aspetti: |
| Sistema paralinguistico (Sistema vocale non verbale) |
|
| Sistema cinestesico (movimenti del corpo) |
|
| Prossemica (l’occupazione dello spazio) |
|
| Aptica (contatto fisico) |
|
Canale
E’ il mezzo attraverso cui l’emittente veicola, o attraverso cui il ricevente ottiene, il messaggio. Può essere inteso sia come il mezzo sensoriale coinvolto nella comunicazione (principalmente udito e vista) sia come il mezzo tecnico esterno al soggetto con cui il messaggio arriva (telefono, fax, e-mail.).
Ogni canalizzazione di un messaggio produce necessariamente una “riduzione di complessità”. Quando comunichiamo, nella nostra mente possediamo un messaggio complesso, dotato di molte sfaccettature e molti livelli di significato: riversando questo messaggio all’esterno, siamo costretti a veicolarlo attraverso un codice, e a “semplificarlo” in modo che possa passare attraverso un canale.
I diversi tipi di canale si differenziano non solo sulla base dei contenuti che veicolano, ma anche sulla base del modo in cui risvegliano o alterano i pensieri e i sensi del ricevente. E’ molto diverso il processo percettivo che attiva una persona di fronte a un libro (canale visivo), ascoltando la radio (canale uditivo), di fronte a uno spettacolo televisivo (entrambi) o assistendo a una lezione universitaria, dove sono stimolati contemporaneamente la vista, l’udito, e tutti gli altri sensi attivi nella comunicazione interpersonale.
Ci sono dunque almeno tre modi di intendere il concetto di canale:
- come mezzo di comunicazione utilizzato
- come processo percettivo interessato dal segnale
- come “messaggio”, ovvero come insieme di processi percettivi che ogni canale stimola in modo differente, i quali influenzano il contenuto del messaggio co-determinandone il significato
E’ il contenuto di ciò che si comunica. E’ strettamente legato al concetto di informazione, e può essere un dato, una notizia o più semplicemente una sensazione, veicolata attraverso segni significativi (frasi, singole parole o suoni, gesti, espressioni, immagini, ecc.) E’ la parte “attiva” dell’atto comunicativo, quella che genera l’effetto di inviare all’ambiente esterno pensieri o informazioni prima contenute solo all’interno della mente dell’individuo che le emette. Il concetto di”messaggio”, apparentemente scontato, è in realtà difficile da afferrare. Se definiamo il termine messaggio dal punto di vista dell’emittente, esso è il mezzo attraverso cui viene veicolata o resa disponibile una informazione, e dunque ricercata un’influenza sociale, un effetto sul ricevente. Se lo definiamo dal punto di vista del ricevente, il messaggio è invece l’interpretazione che il ricevente fa dello stimolo proveniente dall’emittente. Non dobbiamo fare l’errore infatti di credere che il significato del messaggio sia contenuto all’interno del messaggio stesso. Il significato emerge solo dalla lettura contestuale del messaggio e di tutti gli altri elementi della comunicazione. Lettura contestuale che è possibile, però, solo dopo che un soggetto ha deciso di agire inviando al mondo un segnale.
E’ la retrocomunicazione che il ricevente invia all’emittente mentre la comunicazione sta avvenendo. E’ una informazione di ritorno che permette all’emittente, mentre sta comunicando, di percepire se il messaggio è stato ricevuto, capito, approvato, ecc. e dunque di reagire, cercando la via più efficace per raggiungere il risultato che si è prefisso. Nelle normali comunicazioni facciamo un grande uso di feed-back per “aggiustare la mira” rispetto a quello che stiamo dicendo. Se siamo impegnati a convincere qualcuno di qualcosa, mentre parliamo osserviamo periodicamente l’interlocutore per cercare segnali che ci assicurino che stia ascoltando, che stia seguendo il ragionamento, che abbia capito. Se riceviamo segnali di senso contrario, ripetiamo alcune cose, o scegliamo un altro esempio, o alziamo il tono di voce, fino a quando non riusciamo a raggiungere il nostro obiettivo (o decidiamo di rinunciare).
Contesto
E’ il “luogo” (fisico o relazionale) in cui avviene lo scambio comunicativo, ovvero la “situazione” in cui l’atto comunicativo si inserisce (e a cui si riferisce). Il contesto è parte integrante del messaggio, e può cambiare il significato del messaggio stesso: la frase “bene, molto bene” pronunciata da un insegnante significa cose molto diverse se detta al termine di una interrogazione in cui lo studente ha dato buona prova di sé, oppure appena dopo che l’insegnante ha scoperto lo stesso studente copiare durante un compito in classe. Quando inviamo messaggi come la frase “questo mi sembra ok”, è il contesto che permette di comprendere che la parola “questo” si riferisce a un determinato oggetto e non a un altro. In ogni situazione comunicativa reale sono coinvolti molti contesti contemporaneamente, che spesso si sovrappongono. Questo può creare imbarazzo: è ciò che accade se partecipate a una festa in cui sono presenti sia i vostri amici (che richiederebbero da voi un certo linguaggio, un certo tipo di contenuti e un certo comportamento) sia i vostri genitori (che ne richiedono ben altri).